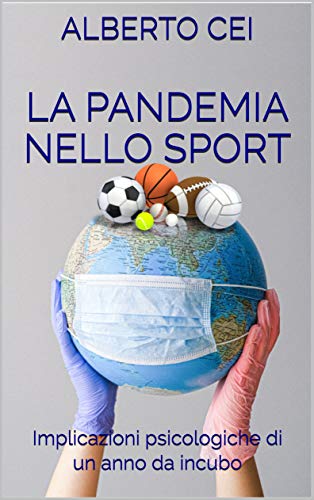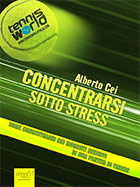Questo articolo spiega con chiarezza le probabili ragioni della tonsillite di Jannik Sinner e i motivi per cui è fortemente sconsigliato partecipare durante questa malattia a eventi agonistici: Keaney LC, et al. The impact of sport related stressors on immunity and illness risk in team-sport athletes. J Sci Med Sport (2018).
Gli atleti sono continuamente esposti a fattori di stress che hanno il potenziale di deprimere le funzioni immunitarie e aumentare il rischio di infezioni, in particolare le infezioni del tratto respiratorio superiore o il comune raffreddore. Infatti, è la malattia infettiva più comune segnalata dagli atleti d’élite. La malattia è di grande preoccupazione per gli atleti poiché può interrompere l’allenamento e le prestazioni.
Per comprendere perché gli atleti sembrano avere un rischio maggiore di infezione, è emerso il campo dell’immunologia dell’esercizio. Gli studi in quest’area si sono principalmente occupati di identificare i marcatori immunitari che possono essere utilizzati per prevedere la suscettibilità degli atleti alle malattie, principalmente negli atleti di resistenza. In particolare, l’immunità della mucosa e le risposte delle citochine dei linfociti T sono state trovate essere determinanti chiave del rischio di infezioni pe questi fattori di stress includono l’allenamento, la competizione, i viaggi, gli ambienti estremi, lo stress psicologico, la privazione del sonno, la cattiva alimentazione e il consumo eccessivo di alcol.
I sintomi comuni includono mal di gola, mal di testa, naso che cola e tosse e possono derivare da cause infettive (eziologia virale, batterica o fungina) o non infettive e infiammatorie (ad esempio causate da allergie, asma e traumi alle membrane epiteliali respiratorie).